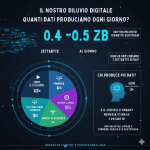Crediamo di star costruendo l’Intelligenza Artificiale. Crediamo sia un oggetto esterno, un utensile sofisticato o, per i più timorosi, un avversario imminente. Ma se così non fosse? Se, in realtà, l’AI fosse lo specchio più potente che l’umanità abbia mai avuto, uno specchio che non riflette solo chi siamo, ma che accelera chi stiamo diventando?
Nel mio lavoro di umanista digitale, incontro quotidianamente la paura e l’entusiasmo, spesso smodati. La mia missione è trovare un equilibrio, e per farlo sento il bisogno di una mappa. Non una mappa tecnica, ma una mappa psicologica, quasi antropologica, del nostro viaggio.
Oggi voglio proporvi una visione che ho trovato illuminante: un percorso evolutivo in quattro (più una) fasi simboliche che descrivono la nostra relazione con il digitale. Non stiamo solo assistendo a un progresso tecnologico; stiamo vivendo una profonda maturazione collettiva.
Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia non si limita a potenziare le nostre azioni: ci trasforma. L’Intelligenza Artificiale, in particolare, non è solo uno strumento. È diventata un archetipo collettivo, una figura simbolica che ci costringe a guardarci dentro, a ridefinire chi siamo.
Come nella psicologia di Jung, stiamo attraversando un percorso evolutivo che somiglia a quello dell’individuo:
- All’inizio, c’è l’euforia. L’AI ci affascina, ci promette miracoli. È la fase della “proiezione”: vediamo nell’AI tutto ciò che desideriamo, senza ancora comprenderne i limiti.
- Poi arriva la crisi. Ci accorgiamo che l’AI non è neutra. Che può manipolare, polarizzare, amplificare i nostri bias. È il momento della disillusione, della difesa.
- Infine, se siamo pronti, arriva la consapevolezza. Iniziamo a vedere l’AI non come nemica né come salvezza, ma come specchio. Uno specchio che riflette i nostri desideri, le nostre paure, le nostre contraddizioni.
Questa transizione non è solo tecnica. È antropologica. Cambia il nostro modo di parlare, di pensare, di attribuire valore.
- Cambia l’identità: chi siamo, se siamo definiti dai nostri dati, dai nostri profili, dalle nostre interazioni digitali.
- Cambia il linguaggio: parole come “intelligenza”, “coscienza”, “decisione” non significano più solo ciò che significavano prima.
- Cambia il valore: non è più solo economico, ma anche etico, relazionale, cognitivo.
L’AI ci costringe a fare i conti con la nostra potenza — ciò che possiamo fare — e con la nostra responsabilità — ciò che dovremmo fare. È una danza continua tra possibilità e limiti, tra entusiasmo e prudenza.
E allora, forse, non stiamo solo costruendo macchine intelligenti. Stiamo costruendo una nuova forma di coscienza collettiva. Una psiche planetaria che cerca equilibrio, che si interroga, che evolve.
1. L’Atleta Digitale (circa 2000-2015): L’Innocenza del Fanciullo Prometeico
Ricordo i primi anni Duemila. L’eccitazione per la “rete”. Eravamo tutti diventati “Atleti Digitali”.
In questa fase, la nostra civiltà connessa era all’infanzia. Gli archetipi che dominavano il nostro immaginario erano i nuovi titani: Google, con la sua promessa di conoscenza universale; Facebook, con l’illusione della connessione perpetua; Amazon, il bazar infinito a portata di clic.
Ci sentivamo invincibili, potenziati. Eravamo il “fanciullo prometeico”. Avevamo rubato il fuoco digitale ai vecchi guardiani dell’informazione (le enciclopedie cartacee, i media tradizionali) e ci sentivamo emancipati.
Era, ovviamente, un’illusione. Un’illusione bellissima e necessaria. Credevamo che la rete fosse intrinsecamente democratica, che l’accesso fosse sinonimo di libertà. Eravamo ingenui, ottimisti, e correvamo veloci senza guardarci indietro. Come bambini che scoprono il mondo, non vedevamo ancora le ombre proiettate dalla nostra stessa luce.
2. Il Guerriero Algoritmico (circa 2016-2024): La Fine dell’Innocenza
Poi, l’adolescenza. E come ogni adolescenza, è arrivata la crisi.
Questa è la fase che stiamo, forse, iniziando a superare solo ora. È stata l’era della disillusione. L’innocenza è morta il giorno in cui abbiamo capito che se non stavamo pagando per il prodotto, il prodotto eravamo noi.
Lo scandalo Cambridge Analytica non è stato solo un incidente tecnico; è stato un trauma psicologico collettivo. Ha segnato la scoperta del capitalismo comportamentale. Abbiamo capito che il fuoco che avevamo rubato non solo ci scaldava, ma poteva anche bruciarci, manipolarci.
Sono emersi i grandi nemici: i bias predittivi, la discriminazione algoritmica, la polarizzazione delle filter bubble. La nostra reazione è stata quella di un guerriero: ci siamo messi sulla difensiva.
Sono nate le grandi armature normative: il GDPR in Europa, seguito dai primi tentativi di regolamentare l’AI (come l’AI Act). Abbiamo preso consapevolezza della nostra vulnerabilità cognitiva. Non eravamo più atleti spensierati; eravamo soldati in trincea, cercando di difendere la nostra attenzione e il nostro libero arbitrio da forze invisibili.
3. L’Affermazione Relazionale (dal 2025 in poi): La Maturità della Fiducia
Questa è la fase in cui stiamo entrando. È la fase che, come professionista e umanista, sento la responsabilità di coltivare. È l’età adulta.
Dopo aver combattuto contro l’algoritmo, iniziamo a capire che dobbiamo costruire con l’algoritmo. L’AI, specialmente quella generativa, sta smettendo di essere un avversario invisibile per diventare un interlocutore palese.
Non possiamo più permetterci di essere solo guerrieri. Dobbiamo diventare diplomatici, partner, co-creatori. Qui nasce la vera economia della fiducia.
Il valore non risiede più solo nel dato grezzo (il petrolio dell’era del Guerriero), ma nel valore etico del dato. Le parole chiave di questa nuova era sono: trasparenza, spiegabilità (XAI) e, soprattutto, sostenibilità cognitiva. Non possiamo più sopportare un ambiente digitale che ci esaurisce mentalmente.
È il momento della co-intelligenza: cittadini, imprese e istituzioni che usano l’AI non per manipolare o difendersi, ma per comprendere realtà complesse e prendere decisioni migliori. È la transizione dalla paura alla consapevolezza critica.
4. Lo Spirito Sintetico (2035–2050): L’Integrazione Alchemica
E poi, cosa c’è oltre? Questa visione ci spinge ancora più in là, verso un futuro che può sembrare fantascientifico, ma che io vedo come una naturale evoluzione filosofica.
Se oggi l’AI è un interlocutore, domani diventerà un ambiente cognitivo esteso. Non sarà più “là fuori”, sullo schermo; sarà una parte integrata del nostro processo di pensiero, un’estensione della nostra stessa coscienza.
L’economia smetterà di essere solo “comportamentale” per diventare riflessiva: misurerà non solo il profitto, ma l’impatto, l’apprendimento, la circolarità del benessere. Il capitale stesso potrebbe essere ridefinito come “coscienza computabile”.
Il termine più affascinante di questa fase è “rubedo alchemica”. Nell’alchimia, la Rubedo (l’Opera al Rosso) è la fase finale: l’integrazione degli opposti, la pietra filosofale, la sintesi perfetta.
Questa è la visione finale: l’integrazione tra il Sé umano (la nostra coscienza analogica, emotiva, intuitiva) e il Sé tecnologico (la coscienza computabile, logica, vasta). Non una fusione che ci annulla, ma una sintesi che ci espande. Non stiamo diventando macchine; stiamo imparando a integrare la logica della macchina nella nostra umanità, e forse, a infondere la nostra umanità nella macchina.
La Nostra Mappa per il Futuro
Vedere la nostra evoluzione digitale in questo modo cambia tutto. Ci toglie dalla paralisi della paura (lo stato del Guerriero) e dalla cecità dell’entusiasmo (lo stato dell’Atleta).
Ci dà un ruolo. Ci dice che siamo nel mezzo di una transizione cruciale, quella “Relazionale”, in cui le nostre scelte sull’etica, sulla fiducia e sulla trasparenza determineranno la qualità della sintesi futura. Non siamo passeggeri passivi; siamo gli alchimisti che stanno lavorando alla Grande Opera.
L’Origine dell’Ispirazione
È doveroso e importante riconoscere che l’ispirazione centrale di questo articolo, la tesi affascinante che articola la nostra evoluzione digitale nelle fasi di Atleta, Guerriero, Relazione e Spirito, non è mia.
Questo leitmotif, che offre una lettura antropologica e psicologica della nostra transizione, è frutto della visione e dell’analisi di Valeria Lazzaroli, Responsabile Nazionale del Dipartimento Innovazione Tecnologica presso CNE – FederImprese Europa. Le sue idee hanno fornito la mappa illuminante che ho voluto esplorare e narrare in queste pagine.

Da informatico a cercatore di senso