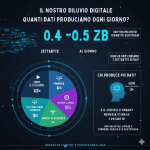Il Futuro non si Prova, si Abita
Sono sempre stato abituato a vedere la tecnologia come una leva di democratizzazione e apprendimento continuo. Eppure, proprio mentre l’intelligenza artificiale si affaccia sul lavoro con forza dirompente, mi trovo ogni giorno a cercare risposte, possibilità, storie e nuovi inizi, perché la vera posta in gioco è il senso del nostro agire. Non il futuro come una minaccia, né una caricatura di progresso, ma un orizzonte da abitare insieme con i nostri dilemmi, dubbi e talenti.
“Apologia del lavoro”: oltre l’allarme euforico
Il rapporto “Intelligenza artificiale, una riscoperta del lavoro umano” mi guida in questo viaggio. Abbandoniamo le narrazioni a tunnel: niente tragedia da automazione, né utopia senza limiti. L’IA irrompe, sì, nella routine produttiva, e secondo le stime più recenti sono circa 10,5 milioni i lavoratori italiani fortemente esposti al rischio di automazione, soprattutto nelle mansioni meno qualificate. I dati sono netti, eppure il mercato dell’IA in Italia cresce vertiginosamente (909 milioni di euro nel 2024), creando nuovi ruoli come data scientist o specialisti di sicurezza informatica, mentre la diminuzione strutturale dei lavoratori (1,7 milioni in meno entro il 2030) viene compensata proprio dall’ingresso della tecnologia.
Ma il vero cambiamento non si misura solo in posti di lavoro perduti o creati: è un profondo rimodellamento della gamma di competenze necessarie. Le hard skills digitali diventano centrali, ma non bastano. Vengono rispolverati pensiero critico, creatività, empatia, capacità di risolvere problemi complessi. Non casualmente il World Economic Forum mette le abilità cognitive e sociali ai primi posti nella classifica delle competenze core per il futuro.
Storie e identità: chi siamo, chi saremo?
Talvolta il cambiamento travolge in modo diverso: più vulnerabili sono artigiani, operai, impiegati d’ufficio, meno chi ha alta istruzione. E le donne, paradossalmente, risultano più esposte all’automazione rispetto agli uomini. Ma anche le nuove generazioni rischiano di crescere in simbiosi con l’IA, imparando un “saper porre domande” digitale che trasforma la memoria da magazzino a struttura di ricerca.
Vedo, fra i miei amici e collaboratori, nuove forme di smart working e team distribuiti. Un dato mi colpisce: chi lavora da remoto è esposto all’IA e al Machine Learning in modo più profondo (fino all’85,5%), ma proprio questa modalità può impoverire relazioni, empatia e coesione sociale – lo smart working riduce l’interazione umana, l’IA rischia di generare relazioni di pseudo-intimità con le macchine. L’identità professionale si trasforma tra divisioni geografiche, demografiche e settoriali: solo chi saprà vivere l’ibrido saprà guidare il cambiamento.
Oltre il lavoro: come l’IA rimodella la società e la nostra umanità
Non basta più parlare di economia digitale. L’intelligenza artificiale diventa catalizzatore interdisciplinare, costringendo filosofi, scienziati, imprenditori, neuroscienziati a dialogare. Il pensiero critico diventa presidio etico contro quella “incoscienza artificiale” che porta a fidarsi ciecamente delle macchine, rischiando una perdita di agency umana e la diffusione di informazioni che nessuno può più filtrare senza giudizio umano.
La voce dei protagonisti è nitida: la sociologa Helga Nowotny esorta a sviluppare l’IA per amplificare le capacità umane, la neuroscienziata Martina Ardizzi sottolinea la plasticità del cervello umano e l’importanza della memoria come strategia di ricerca, Massimo Chiriatti mette in guardia dal rischio di passività e invita a mantenere la capacità di porsi domande, di scegliere, di attribuire senso. Mario Ubiali ribadisce il valore dell’astrazione e della creatività, mentre Daniele Pucci chiama la tecnologia robotica a sostenere l’evoluzione della società. Il fisico Roberto Trotta sfida le narrazioni dicotomiche e Giulio Starace, da OpenAI, ci ricorda i limiti attuali dei modelli IA nell’inventare davvero il nuovo.
Visioni per il futuro: dalle strategie educative all’azione politica
La vera partita la si gioca sull’educazione e sulla leadership. La rivoluzione delle competenze non può più ignorare il “learn by doing”: serve sviluppare percorsi formativi in cui la tecnologia sia tutor socratico, alleata del pensiero critico, non sostituto dell’intelligenza umana. Solo una formazione che promuova l’autonomia, la collaborazione uomo-macchina e la capacità autonoma di giudizio può assicurare che la tecnologia sia al servizio del progresso e non un fine a sé.
Il valore del fare umano resta un punto politico: delegare completamente all’IA, avverte la neuroscienza, significa perdere connessione con la realtà materiale e con la propria autodeterminazione. Non è questione di difesa ideologica, ma di scelta attiva: preservare l’esperienza diretta, valorizzare le pratiche e la collaborazione, costruire una cultura aziendale che non sacrifichi relazioni e crescita personale.
L’Umanesimo Digitale: un appello per condividere conoscenza e visione
Il rapporto si chiude con un invito chiaro: il futuro dell’IA non è scritto, ma dipende dalle scelte che faremo oggi. La vera sfida non è fermare il progresso tecnologico, ma assicurarsi che sia al servizio dell’umanità, guidato da valori etici e non solo da logiche di mercato. Solo attraverso una collaborazione consapevole tra uomo e macchina, e attraverso un’educazione che promuova autonomia, pensiero critico e competenze umane, potremo garantire che l’evoluzione dell’IA sia strumento di progresso autentico.
Credo, da umanista digitale, che la tecnologia sia potente solo se guidata dalla cultura e dai valori etici. La democratizzazione della conoscenza passa anche attraverso la responsabilità sociale: chi conosce deve aiutare chi è più fragile, soprattutto ora che la confusione generata da deepfake, manipolazione, disinformazione rende vulnerabile chiunque.
Il futuro non è scritto: la sfida è far sì che l’IA diventi alleata della creatività, dell’etica, della collaborazione. Bisogna costruire insieme un nuovo patto sociale capace di affrontare l’incertezza senza perdere la forza della nostra umanità.
❓ FAQ Intelligenza Artificiale e Lavoro
Domande frequenti dal Rapporto Fondazione Randstad AI Humanities 2025
💡 L’Impatto dell’IA sul Mercato del Lavoro
Secondo il rapporto Randstad Research 2025:
Circa 10,5 milioni di lavoratori italiani sono considerati altamente esposti al rischio di automazione. Di questi:
- 46,6% sono professionisti a bassa qualifica
- 43,5% sono professionisti mediamente qualificati
- 9,9% sono altamente qualificati
Le professioni più vulnerabili sono artigiani, operai specializzati, agricoltori, conduttori di impianti e impiegati d’ufficio.
La risposta è entrambi. Il rapporto parla di due dimensioni di impatto:
Margine Estensivo (creazione/distruzione):
- Distrugge: mansioni routinarie e, sempre più, compiti cognitivi non routinari
- Crea: nuove figure come data scientist, ingegneri ML, specialisti sicurezza informatica
- Il mercato IA italiano ha raggiunto 909 milioni di euro nel 2024
Margine Intensivo (trasformazione competenze):
- L’impatto più profondo: la stragrande maggioranza dei lavori sopravviverà, ma cambierà radicalmente
Secondo il World Economic Forum 2025, oltre alle hard skills digitali, le competenze core per il futuro includono:
Hard Skills (tecniche):
- Alfabetizzazione digitale e IA
- Familiarità con la logica algoritmica
- Analisi dei dati
- Programmazione e Machine Learning
Soft Skills (umane) – ancora più importanti:
- Pensiero analitico e critico
- Creatività (ricercata con aumento del 12% in Europa, 16% negli USA entro 2030)
- Intelligenza emotiva e empatia
- Leadership e influenza sociale
- Problem-solving complesso
- Adattabilità e resilienza
👥 Chi è più vulnerabile all’IA?
Sì, secondo l’analisi demografica del rapporto.
Le donne risultano maggiormente esposte all’IA e al Machine Learning rispetto agli uomini. Questo riflette:
- Una concentrazione storica di donne in ruoli amministrativi e di supporto
- Una minore rappresentanza nelle professioni STEM
- La vulnerabilità di mansioni tradizionalmente femminili all’automazione
Tuttavia, anche le professioni intellettuali sono fortemente esposte all’IA, richiedendo una ridefinizione delle competenze anche per i livelli più alti.
Sì e no. Dipende dalle competenze.
I lavoratori più giovani (15-24 anni):
- Mostrano maggiore ricettività e attitudine all’apprendimento digitale
- Hanno vantaggio nell’adattarsi a nuove tecnologie
- Ma rischiano di crescere in simbiosi con l’IA, sviluppando un pensiero critico meno indipendente
I lavoratori anziani:
- Possono incontrare difficoltà nell’aggiornamento delle competenze
- Ma beneficiano di esperienza consolidata e soft skills mature
Conclusione: L’istruzione è il vero fattore protettivo, non l’età.
Sorprendentemente, sì.
Il rapporto scopre una correlazione rilevante tra smart working e esposizione all’IA:
- Chi non fa mai smart working: 48,3% alta esposizione
- Chi lavora da remoto meno del 50% del tempo: 85,5% alta esposizione
- Chi lavora da remoto 50% o più del tempo: 82,5% alta esposizione
Ma questo crea una sfida paradossale: lo smart working riduce le interazioni umane, mentre l’IA richiede maggiore collaborazione tra persone. Le aziende devono gestire questa tensione.
🧠 Cognizione e Pensiero Critico
Concetto coniato da Massimo Chiriatti (Chief Technology Innovation Officer di Lenovo Italia).
L'”incoscienza artificiale” descrive il rischio di fidarsi eccessivamente delle macchine che forniscono risposte senza una reale consapevolezza di ciò che dicono.
L’IA generativa può:
- Fornire informazioni plausibili ma inesatte (allucinazioni)
- Amplificare pregiudizi presenti nei dati di addestramento
- Sembrare competente su argomenti di cui in realtà non comprende il significato
Conseguenza: Il pensiero critico umano diventa ancora più essenziale. L’intelligenza umana non si limita a trovare risposte, ma include la capacità di porsi le giuste domande.
Secondo la neuroscienziata Martina Ardizzi:
La memoria umana si sta trasformando da “magazzino” a “struttura strategica di ricerca”.
Cosa significa?
- Passato: La memoria serviva ad accumulare e conservare informazioni
- Oggi: Con accesso illimitato a informazioni, la memoria si evolve verso la capacità di selezionare, filtrare e discernere le informazioni rilevanti
Implicazione positiva: Il cervello umano si adatta (plasticità cerebrale) e sviluppa nuove capacità.
Implicazione critica: Questo richiede una maggiore alfabetizzazione digitale e pensiero critico. Il rischio è delegare completamente questa selezione all’IA, perdendo capacità di discernimento autonomo.
Sì, secondo il rapporto, esiste un rischio concreto.
L’interazione prolungata con IA emotiva può generare:
- Pseudo-intimità: Relazioni con chatbot che sembrano autentiche ma non lo sono
- Erosione dell’empatia: Meno pratica con le complessità e imperfizioni delle relazioni umane reali
- Perdita di competenze relazionali: Comunicazione non verbale, lettura delle emozioni, gestione del conflitto
Particolarmente a rischio: le nuove generazioni che crescono con l’IA come strumento comunicativo principale.
Soluzione: Le aziende devono ripensare gli spazi di lavoro come hub di connessione umana, preservando il valore dell’interazione diretta.
🚀 Strategie per il Futuro
Da un modello tradizionale a “learn by doing” (apprendimento pratico).
Cambiamenti necessari:
- Dalla teoria: Lezione frontale, libri → Alla pratica: Learn by doing, prototipazione
- Dal passivo: Ricettore di informazioni → All’attivo: Risolutore di problemi
- Dalla memorizzazione: Magazzino di informazioni → Alla selezione: Struttura strategica di ricerca
- Ruolo dell’IA: Da assente a tutor socratico che supporta il pensiero critico
Obiettivo: Non sostituire l’intelligenza umana, ma costruire un ecosistema in cui la tecnologia sia alleata della creatività.
Equilibrio critico: Sviluppare sia hard skills digitali che soft skills umane (creatività, pensiero critico, empatia).
Le aziende devono fare tre cose:
1. Ripensare l’organizzazione del lavoro ibrido
- Gestire la tensione tra smart working (che riduce interazioni) e IA (che richiede collaborazione)
- Creare spazi fisici come hub di connessione, creatività e socializzazione
- Evitare la creazione di “due velocità” tra lavoratori in sede e da remoto
2. Preserve il valore delle interazioni umane
- L’IA può aumentare la produttività, ma non deve sacrificare l’esperienza diretta e la crescita professionale
- Investire in team building e coesione sociale
3. Guidare consapevolmente l’adozione dell’IA
- Non applicare IA solo per replicare vecchi processi, ma per innovare
- Mantenere il controllo etico sugli algoritmi e i dati
Il “fare” ha una dimensione politica profonda, spesso sottovalutata.
Perché il “fare” è politico?
- Implica azione diretta e una presa di posizione nel mondo
- Connette la nostra comprensione alla realtà materiale
- Garantisce agency (capacità di azione e autodeterminazione)
- Promuove responsabilità etica diretta per le conseguenze
Il rischio dell’automazione totale:
- Perdita di connessione con la realtà materiale
- Erosione della capacità di azione autonoma
- Delega della responsabilità agli algoritmi
Soluzione: Le esperienze pratiche non sono secondarie—sono fondamentali per la coesione sociale e lo sviluppo individuale. Le aziende e la società devono valorizzare il “fare umano” consapevolmente.
Il rapporto sottolinea la necessità di una regolamentazione consapevole e inclusiva.
Punti critici:
- Trasparenza e governance: Chi possiede una familiarità con l’IA ha il dovere di alfabetizzare il resto della popolazione
- Protezione dei dati e sovranità: Sviluppare infrastrutture proprie per garantire sicurezza (es. il ritardo europeo vs Cina/USA)
- Alfabetizzazione diffusa: L’AI Act richiede alle imprese di fornire formazione, ma le formulazioni sono ancora vaghe. Serve concretezza
- Protezione dei vulnerabili: Professionisti, anziani e persone meno istruite sono più esposte a manipolazione e disinformazione
Raccomandazione chiave: L’IA Act offre “un’ancora di eticità” che, con un approccio sistemico, può renderci un’alternativa competitiva globale (non solo una difesa). L’Europa deve usarla strategicamente.
🌍 La Visione: Umanesimo Digitale
L’IA sta agendo come catalizzatore interdisciplinare, abbattendo i silos tra i saperi.
Discipline che devono convergere:
- Etica e Filosofia: Questioni di responsabilità, equità, uso consapevole
- Neuroscienze: Come il nostro cervello si adatta alle nuove tecnologie
- Scienza dei Dati: Prevenzione dei bias, trasparenza algoritmica
- Scienze Sociali: Impatto sul lavoro, le relazioni, la coesione sociale
- Economia: Distribuzione della ricchezza, nuove forme di valore
Lezione centrale: Non si tratta di scegliere tra IA o uomo. Si tratta di imparare a lavorare insieme all’IA, non in alternativa ad essa, valorizzando le competenze umane più preziose.
“Per un’apologia del futuro del lavoro”—il futuro non è scritto.
Tre conclusioni chiave:
1. L’IA non è minaccia o opportunità: è uno strumento da governare
- La vera sfida non fermare il progresso, ma assicurare che sia al servizio dell’umanità, non solo della logica di mercato
2. La collaborazione uomo-IA deve essere virtuosa
- L’IA amplifica e integra le competenze umane, liberando energie per attività a maggiore valore aggiunto
- Non devono competere, ma cooperare
3. L’umanesimo digitale è l’unica strada credibile
- Democrati della conoscenza, pensiero critico, empatia e responsabilità sociale devono guidare lo sviluppo dell’IA
- Il futuro del lavoro è umano, se lo costruiamo insieme consapevolmente
Da informatico a cercatore di senso